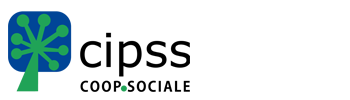Lunedì 9 marzo 2020 – Martedì 9 marzo 2021. È passato un anno dal primo lockdown nazionale ed ho chiesto ai nostri ospiti se volessero raccontarmi questo anno. Quando ho proposto questo tema il mento di F. ha quasi toccato terra – “Ancora Covid?” – il che rende abbastanza bene lo sfinimento, il non poterne più. F. c’era a marzo scorso, quando questa roba fantascientifica ha fatto irruzione nelle nostre vite e quindi a Rajo. Era tra quelli che sono rimasti per due mesi chiusi in comunità quando il cataclisma accadeva in televisione e cercavano di leggerlo negli occhi stanchi di noi operatori (non nei miei perché ci ho messo mesi a capire come non far appannare gli occhiali con la mascherina). “Com’è fuori? Com’è la situazione a Terni?” A saperlo com’era la situazione a Terni. Al massimo avrei potuto dirgli che la E45 era deserta e che il mio vicino di casa ogni giorno alle 18 faceva sentire Celentano a tutto il quartiere. Erano i tempi in cui ai bollettini delle 18 di Borrelli si rispondeva coi canti dai balconi e coi tricolori alle finestre come fossero i mondiali di calcio. Era come se, di fronte allo sgomento e a questa nuova spaventosa espressione “distanziamento sociale”, si sentisse il bisogno di stringersi tutti. Era una reazione emotiva che sarebbe durata poco – presto si sarebbe trasformata nella caccia al runner, nel rancore verso il vicino di casa che ospita in casa clandestinamente l’anziana madre, e nell’astio per Celentano – ma non per questo non autentica. È chiaro che di questi tempi qualsiasi cosa diventi virale poi perda di senso, ma quando ti arriva una bomba così addosso, e non ci capisci più niente, e non puoi parlarne con gli amici al bar, tu quella emotività da qualche parte devi metterla, ognuno con gli strumenti che ha.
Tornando a Rajo, questa prima ondata emotiva è espressa in due post molto belli pubblicati un anno fa da Barbara – Noi operatori sociali, sempre in viaggio verso Itaca – e da Marta – Come possiamo oggi ridurre le distanze. Nella pratica abbiamo inaugurato uno spazio quotidiano in cui ci riunivamo, educatori ed ospiti, ci stringevamo e in qualche modo cercavamo di ridurre le distanze; abbiamo aperto uno spazio quotidiano di accesso a internet, perché questa chiusura dentro potesse contare almeno su qualche finestra in più; abbiamo sostituito le telefonate settimanali ai parenti con videochiamate, perché le visite a casa erano sospese. Anche questo blog lo abbiamo iniziato a scrivere in quel periodo. In generale ci siamo sentiti in dovere di essere più propositivi per colmare delle mancanze, per rispondere in modo diverso a bisogni vecchi e nuovi dei nostri ospiti.
Si potrebbe pensare che per una comunità terapeutica poco cambi una situazione come quella che viviamo. È singolare che quando mercoledì scorso ho chiesto agli ospiti come avessero vissuto quel periodo iniziale e cosa gli fosse mancato di più, di primo acchito abbiano dato una risposta su questa linea: “Noi non vedevamo il mondo fuori, lo vedevamo solo in televisione. Tra virgolette eravamo anche privilegiati perché in comunità si vive comunque una situazione di socialità, non abbiamo dovuto fronteggiare la solitudine”. Ma un’idea del genere è sostenibile solo se si pensa ad una comunità terapeutica come una sorta di microcosmo chiuso. Rajo, così come molte altre comunità per dipendenze patologiche, lavora sull’esterno almeno quanto lavora sull’interno. La cura delle reti – familiari, sociali, professionali, istituzionali – e delle competenze relazionali è centrale nel nostro lavoro. Sono venute meno tante risorse che offre il territorio e la possibilità di sperimentarsi in relazioni, di costruirsi delle autonomie al di fuori dei confini della comunità.
Tutti gli ospiti hanno indicato nella famiglia ciò che più gli manca in questo periodo. Quando a R. ho chiesto di questo anno lui mi ha raccontato di aver passato il primo lockdown in comunità e che ha preso alla lettera il liberi tutti del 4 maggio 2020 abbandonando il percorso. Fino al suo rientro in comunità però, mi dice, non c’è niente da raccontare perché stava male. E. mi dice che il primo lockdown non le ha cambiato niente perché usava sostanze tutti i giorni mantenendo la stessa routine legata al consumo, quindi non si è nemmeno accorta del cambiamento. Quelle famiglie che gli mancano oggi, ieri erano più lontane. Il punto è che la dipendenza è un enorme lockdown, una serrata, è distanziamento sociale. Togliere queste opportunità a persone che stanno affrontando un percorso di uscita dalla dipendenza equivale a sottrarre delle risorse preziosissime. Queste risorse, oggi, siamo chiamati a sostituirle, a trasformarle, a reinventarle.
P. mi ha parlato dello stress causato dal muoversi male dentro tutte le norme e restrizioni, che porta a fare il doppio della fatica nel fare la stessa cosa. Mentre parlava mi sono sentito toccato. Lì per lì ho pensato a quando durante il primo lockdown fosse faticoso e stressante fare la spesa: tra una serie che sembrava infinita di pratiche nuove e scomodissime, e la paura che il virus fosse annidato ovunque, tornavo a casa in una zuppa di sudore. Ma in realtà la fatica è un’altra. In questo anno ci siamo dovuti reinventare per restare noi stessi: è stata tosta, è tosta, siamo stanchi ma teniamo botta
Antonio